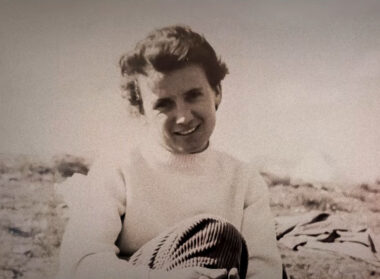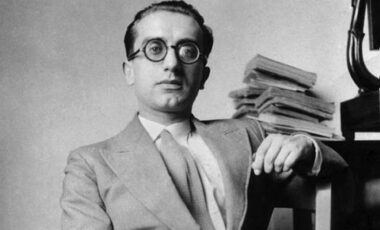Le donne e il loro corpo, solo il 55% sceglie autonomamente
Tutti i dati del rapporto Unfpa-Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione intitolato 'Il corpo è mio. Diritto all'autonomia e all'autodeterminazione'

ROMA – La ‘bodily autonomy’, in italiano ‘autonomia sul corpo’ o ‘autonomia corporea’, è il diritto di ciascun essere umano a decidere liberamente sul proprio corpo e sul proprio futuro, senza violenza o coercizione, e comprende la possibilità di scegliere se e con chi fare sesso, se e con chi progettare una gravidanza e la libertà di cercare e ricevere assistenza medica tutte le volte che se ne senta il bisogno. Eppure donne e ragazze in tutto il mondo affrontano molte limitazioni alla propria ‘bodily autonomy’, con conseguenze anche gravi per la loro salute, il loro benessere e potenziale di vita. Proprio su questo tema si concentra il Rapporto sullo stato della popolazione nel mondo 2021, presentato oggi in contemporanea mondiale da Unfpa-Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e intitolato ‘Il corpo è mio. Diritto all’autonomia e all’autodeterminazione’.
SOLO IL 55% DELLE DONNE SCEGLIE LIBERAMENTE DEL PROPRIO CORPO
In base alle stime del rapporto Unfpa 2021, solo il 55% delle donne a livello globale può scegliere liberamente in tutte e tre le dimensioni dell’autonomia corporea stabilite dall’indicatore Sdg (Sustainable Development Goal) 5.6.1, fissato dalle Nazioni Unite con l’adozione dell’Agenda 2030 per aiutare i governi a tenere traccia dei processi compiuti rispetto al diritto alla salute sessuale e riproduttiva e dei diritti riproduttivi per tutte e tutti (5.6).
L’indicatore si basa sulla risposta data da donne tra i 15 e i 49 anni a queste tre domande: ‘Chi decide di solito in che modo tutelare la tua salute?’; ‘Chi decide di solito se devi assumere o meno dei contraccettivi?’; ‘Puoi dire di no a tuo marito o al tuo partner, se non vuoi avere un rapporto sessuale?’. Solo quelle capaci di prendere le proprie decisioni in tutte e tre le dimensioni sono considerate veramente autonome.
LA GEOGRAFIA DELL’AUTONOMIA CORPOREA SULLA BASE DI SDG 5.6.1
Tra i 57 Paesi coperti dall’indicatore 5.6.1, quello con il punteggio più alto rispetto all’autonomia del corpo è l’Ecuador (87%) in America Latina, quelli con la percentuale più bassa sono Niger e Senegal, nell’Africa sub-sahariana (entrambi al 7%). Regione, questa, che registra complessivamente una cifra relativa all’Sdg 5.6.1 inferiore al 50% assieme all’Asia centrale e meridionale, mentre la situazione migliora nettamente in Asia orientale e sud-orientale, in America Latina e nei Caraibi, dove la percentuale cresce al 76%, con variazioni anche importanti nell’ambito della stessa regione.
INCONGRUENZE NELLE TRE DIMENSIONI
Non è detto che un’alta percentuale in una dimensione corrisponda allo stesso risultato nelle altre due. Se in Mali, ad esempio, il 77% delle donne decide autonomamente sui contraccettivi, solo il 22% è in grado di farlo nella ricerca dell’assistenza sanitaria. In Etiopia, invece, a fronte del 53% di donne che si sentono libere di dire no al sesso, il 94% sceglie in modo indipendente sui contraccettivi.
OLTRE I PARAMETRI DELL’INDICATORE 5.6.1
Sull’autonomia corporea di donne e ragazze, però, il diritto internazionale va oltre i parametri stabiliti dall’indicatore Sdg 5.6.1 e prende in considerazione anche altri aspetti. Dalle violenze sul corpo, come lo stupro, espressamente criminalizzate ormai in tutti i Paesi, alle pratiche dannose che ricalcano disuguaglianze di genere, come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e/o forzati. Fino alle sterilizzazioni forzate, gli stupri omofobici, transfobici o coniugali, i test di ‘verginità’, i delitti ‘d’onore’, la coercizione riproduttiva, o le leggi che in alcuni Paesi ancora permettono agli stupratori di sposare la donna per sfuggire alla pena.
Alcuni di questi abusi hanno conseguenze gravi sulla salute e sul benessere delle donne. È il caso dello ‘stupro coniugale’, in cui, oltre al danno psicologico, si riscontrano lesioni fisiche legate al sesso forzato, gravidanze indesiderate, aborti spontanei e malattie sessualmente trasmissibili come l’Hiv. Alcuni studi hanno poi riscontrato una correlazione tra stupro coniugale e matrimonio precoce, mentre ci sono ancora Paesi dove gli uomini condannati per violenza sessuale possono far annullare la sentenza sposando la donna violentata (tra questi: Algeria, Angola, Bahrain, Bolivia, Camerun, Repubblica Dominicana).
SOLO 56% PAESI PROMUOVE EDUCAZIONE SESSUALE COMPLETA
L’80% dei Paesi a livello mondiale ha leggi che tutelano la salute e il benessere sessuale, il 75% norme che garantiscono un accesso completo e paritario alla contraccezione, il 56% ha leggi che sostengono un’educazione completa alla sessualità.
CHE COS’È SDG 5.6.2
Sdg (Sustainable Development Goal) 5.6.2, il secondo indicatore fissato dalle Nazioni Unite con l’adozione dell’Agenda 2030 per aiutare i governi a monitorare i progressi verso il rispetto al diritto alla salute sessuale e riproduttiva e dei diritti riproduttivi per tutte e tutti (5.6), si occupa di misurare l’esistenza di leggi e regolamenti che garantiscono un accesso completo e uguale per tutte le persone ad assistenza, informazioni ed educazione sulla salute sessuale e riproduttiva e l’eventuale presenza di restrizioni, come i limiti di età o la richiesta del consenso del coniuge.
Sono quattro gli argomenti presi in esame (maternità; cura, contraccezione e pianificazione familiare; educazione sessuale completa e informazione; salute e benessere sessuale), a loro volta divisi in componenti.
LA GEOGRAFIA DELL’AUTONOMIA CORPOREA SULLA BASE DI SDG 5.6.2
Tra tutti i Paesi che hanno riportato dati per questo indicatore, i cinque col valore complessivo più alto sono Svezia (100), Uruguay (99), Cambogia, Finlandia e Paesi Bassi (98).
Sud Sudan (16), Trinidad e Tobago (32), Libia (33), Iraq (39) e Belize (42), i cinque Paesi con i valori più bassi. Per le singole componenti sono riportati dati da 107 governi nazionali, ma sono solo 75 i Paesi con dati completi per l’indicatore. In questo gruppo di Stati in media il 73% delle leggi e dei regolamenti necessari per garantire un accesso pieno ed equo a salute e diritti sessuali e riproduttivi risultano essere a posto.
Nel 93% di 79 Paesi che hanno fornito i dati sulle interruzioni di gravidanza l’aborto è legale. La restrizione citata più frequentemente per l’interruzione di gravidanza è l’autorizzazione da parte di un medico, che però può essere interpretata come una discriminazione contro le donne che devono affrontare barriere all’accesso ai servizi sanitari. L’80% dei 79 Paesi hanno comunque leggi o regolamenti che garantiscono l’accesso all’assistenza post-aborto, a prescindere dallo status giuridico in cui avviene.
COSA FARE PER DIFENDERE IL DIRITTO ALL’AUTONOMIA CORPOREA DELLE DONNE
Secondo lo Stato della popolazione 2021, realizzare l’autonomia corporea “si può e si deve”. Il primo passo “è affermare il concetto stesso”, perché sono ancora “troppe le persone inconsapevoli di avere il diritto di fare delle scelte sul proprio corpo e sul proprio futuro”, si legge sulla sintesi del rapporto redatta da Unfpa. Fattore determinante per le libere scelte delle donne e ragazze su salute sessuale e riproduttiva è il “livello di istruzione”: quanto più le giovani sono istruite tanto più sono e saranno autonome fisicamente e libere di autodeterminarsi a livello sessuale.
Cruciali anche il cambiamento delle “norme sociali” dannose, il “miglioramento delle opportunità di sostentamento” e l’ampliamento dei “ruoli di leadership delle donne nelle loro comunità”. Fondamentale poi “nel sostenere l’autonomia corporea di chi cerca informazioni e cura” il ruolo del personale sanitario, che deve avere una “formazione specifica” riguardo alle questioni di genere. Leggi e regolamenti “possono avere un impatto significativo sui diritti delle donne” e devono “essere allineati sui diritti umani” conquistati a livello globale e conosciuti da magistratura e forze di polizia.
IL MONITO DI NATALIA KANEM, DIRETTORA ESECUTIVA DI UNFPA
“Grazie alla nostra leadership all’interno del nuovo Generation Equality Action Coalition on Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, e attraverso questa edizione dello ‘Stato della popolazione mondiale’, Unfpa intende sottolineare la ragione per cui l’autonomia del corpo è un diritto globale da difendere e sostenere- scrive nella premessa al Rapporto 2021 Natalia Kanem, direttora esecutiva di Unfpa- Il rapporto mette in luce le conseguenze spesso gravissime quando il diritto all’autonomia corporea e all’autodeterminazione è disatteso; molte di tali conseguenze si sono ulteriormente aggravate con le pressioni della pandemia di Covid-19. Il progresso autentico e duraturo- spiega più avanti- dipende soprattutto dall’eliminazione delle disuguaglianze di genere e di tutte le forme di discriminazione, nonché dalla trasformazione delle strutture economiche e sociali che le consentono e perpetuano. Gli uomini devono diventare nostri alleati in questo– è il monito di Kanem- Tutte e tutti insieme dobbiamo adoperarci per contrastare le discriminazioni ovunque e ogni volta che le incontriamo. Tolleranza- conclude- significa complicità”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it