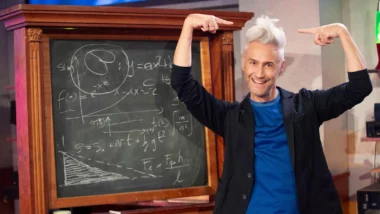Il 2015 in sedici dischi – LEGGI
Sicuramente manca qualcosa, probabilmente c'è qualche scelta discutibile, ma ci sono belle cose. Non c'è un ordine, non è una classifica. Alzate il volume, non serve altro

ROMA – Da Kendrick Lamar ai Songhoy Blues, da Natalie Prass alle Ibeyi. Da Petite Noir a Leon Bridges, dai Chvrches agli Alabama Shakes. Tirando le somme di questi dodici mesi, mi rendo conto che il (mio) 2015 è stato un ottimo anno per la musica afroamericana e per tante eccezionali cantanti. Qui racconto sedici dischi tra i migliori che ho ascoltato.
Sicuramente manca qualcosa (Grimes, Floating Points, Eska, Holly Herndon, Courtney Barnett, Bassekou Kouyate’ & Ngoni Ba, Tobias Jesso Jr, D’Angelo), probabilmente c’è qualche scelta discutibile, ma ci sono belle cose. Non c’è un ordine, non è una classifica. Alzate il volume, non serve altro.
“To Pimp a Butterfly” – Kendrick Lamar
Da Cleveland a Washington, le marce e le proteste dei neri d’America quest’anno hanno una nuova colonna sonora. Nelle città in rivolta si canta ‘Alright’ di Kendrick Lamar, mix di sfida alla polizia che “ci vuole uccidere per strada” e fiducia in un domani dove tutto “andrà bene”. A 28 anni, Lamar è il presente e il futuro della black music. Dentro ‘To Pimp a Butterfly’ c’è rap, soul, funk, hip hop. Il suono potentissimo di una band che suona strumenti veri. Le sue canzoni, dicono, sembrano micro sceneggiatute pronte per Spike Lee. Nascono dall’utopia musicale di George Clinton, Sly Stone, Prince, Outkast. Campionamenti e idee che dureranno per anni, che fanno discutere. Ta-Nehisi Coates, brillante mente della letteratura americana contemporanea, dice: “Sono un nero negli Stati Uniti. Non posso garantire la sicurezza di mio figlio. Non posso dirgli che andrà tutto bene. L’unica cosa che posso fare è non sostenere questa menzogna”. Nei testi di Lamar c’è un rauco ottimismo e oggi per le strade d’America la musica è la sua: “Nigga, we gon’ be alright”.
“Music in Exile” – Songhoy Blues
Dai concerti sotto agli alberi di mango ai palchi dei festival europei. Nel giro di un anno la vita dei Songhoy Blues è cambiata assai: la storia vuole che questo quartetto che suona blues abbia lasciato il Mali perché la loro musica era incompatibile (è un eufemismo) con l’ascesa dei fondamentalisti islamici. Emigrati in Inghilterra, in pochi mesi sono diventati un fenomeno della world music. Hanno pubblicato un ottimo disco, ‘Music in Exile’, chitarroso e prodotto con un gusto molto occidentale. Sul finire dell’anno hanno avuto una ventata di popolarità legata agli attentati di Parigi e Bamako. Loro, musicisti maliani scappati dal terrorismo, simbolo di ribellione, integrazione, convivenza. Chissà che ne pensano. Noi voliamo basso e ci spariamo le loro chitarre. Ah, dal vivo sono una bomba: un quartetto di blues ruvido e incalzante, con un cantante capace di dimenarsi come James Brown o attorcigliarsi alla Michael Jackson.
“VEGA INTL. Night School” – Neon Indian
Vi inorridisce immaginare Prince presentarsi alla stampa in calzini bianchi e infradito con la zeppa (lo ha fatto veramente)? Vi lascia confusi la scelta di fare un tour solo voce e piano? Non disperate, abbiamo il funk che fa per voi. ‘VEGA INTL. Night School’, terzo disco dei texani Neon Indian, vi riconciliera’ col giusto groove. Le canzoni sono un millefoglie di synth, campionamenti, basso e chitarre. E’ un’abbuffata di musica da ballare, dove tutto luccica, suda, s’inzuppa di alcol e fumi notturni. ‘VEGA INTL. Night School’ è un manuale di produzione, un abbecedario dello studio di registrazione. Se qualche malalingua vi dirà che gli ricorda Jamiroquai, voi rilanciate e dite che avete piazzato l’album tra quelli dei Daft Punk e Cerrone. Poi invitate l’amico a fare un test, come Kevin Kline in ‘In&Out’. Alzate il volume, mandate una traccia a caso. E contate i secondi che riuscirà a resistere. Dovrà ammetterlo anche lui: il Texas non ha mai suonato così funky.
“Every Open Eye” – Chvrches
Altro che chitarre, la migliore musica indie, termine ormai irrimediabilmente compromesso, oggi si fa con le tastiere e l’elettronica. E’ pensata per ballare; è ballata per pensare. ‘Every Open Eye’ è il secondo album dei Chvrches, trio scozzese guidato dalla tostissima Lauren Mayberry. Un disco accattivante, che accende e trascina dal primo ascolto. E’ l’album con cui i Chvrches meriterebbero di sfondare tra il grande pubblico. Un suono pulito, potente, luccicante e moderno. Quarantadue minuti senza mai rallentare. Tante ottime canzoni, tra cui ‘Clearest Blue’, pezzo perfetto per la prossima stagione dei festival. Musica da mandare a palla per riempire la pista o da serbare per un’immersione solitaria in cuffia. Funziona sempre.
“Sound & Color” – Alabama Shakes
Inutile girarci intorno: non fosse per la voce, la chitarra, la presenza di Brittany Howard, gli Alabama Shakes sarebbero uno dei tanti gruppi che ancora si ostinano a fare ‘southern rock’ per qualche centinaio di spettatori. E invece hanno già venduto tanti dischi e riempito palazzetti. Sono persino sopravvissuti al successo del primo album e hanno messo a punto un suono da leccarsi i baffi. ‘Sound & Color’ dice tutto dal titolo. Una cucina del Sud americano, dove i piatti bollono per ore, colorati, pieni zeppi di spezie e ingredienti. Soul, rock, psichedelia, musica per viaggiare o arrostire le pannocchie sotto al sole. Sfumature e suggestioni, una una sezione ritmica da urlo: sembra di ascoltare i Roots che rifanno i classici del rhythm’n’blues. Il paragone con Janis Joplin o con i Black Keys ci sta, ci mancherebbe. Il disco è però fresco: cita tante influenze ma ha carattere da vendere, familiare e sorprendente. Da cuocere a lungo, a fuoco lento.
“Natalie Prass” – Natalie Prass
Cercate un disco “bello”? Un’opera d’arte e d’amore dalle melodie limpide, il suono impeccabile e gli arrangiamenti sontuosi? L’omonima opera prima di Natalie Prass è quel disco. Cresciuta in Virginia con la radio accesa sul soul di Dionne Warwick e Al Green, Prass si è guadagnata da vivere scrivendo musica per la pubblicità. Poi l’incontro con Matthew E. White nei suoi Spacebomb studios, la sala d’incisione che sta diventando il forno dove si cucina l’american sound doc. Col suo aiuto, Prass ha sfornato nove deliziose madeleine. Assaggiatele, senza vergogna, abbandonatevi ai ricordi. Sanno di Carole King, Joni Mitchell, Judy Garland, Stevie Nicks, di Broadway e Memphis. Prass canta di amori finiti male, ma resta spiritosa, allegra. Gli arrangiamenti sono lussureggianti, creano un suono senza età, colorato; ci sono archi e riff di fiati commoventi per quanto sono belli; la produzione di Matthew White è dettagliatissima (fatevi un regalo: ascoltatelo in cuffia). Un disco a cui dedicare tempo, vi catturerà.
“At Least For Now” – Benjamin Clementine
Non credo ci siano molti dischi in giro quest’anno più emozionanti di ‘At Least For Now’. Sto mentendo. Impossibile che quest’anno abbiate ascoltato qualcosa di più emozionante del debutto di Benjamin Clementine. La voce profonda, ampia, pazzesca; il suo modo di percuotere il pianoforte, piegandolo alla sua visione. Fresco di vittoria del Mercury Prize, Clementine ha una storia da film. Origini ghanesi, cresciuto a Londra, si sposta a Parigi. Qui canta, dipinge, scrive. Finisce a suonare nei metrò (ci sono i video su Youtube se non ci credete), dove viene notato e messo sotto contratto. Semplice nella strumentazione (un piano, un basso, qualche arco) il disco è un rosario di ballate su cui far scorrere le dita e il cuore. Chiudete gli occhi, li sentite? Sono Nina Simone, Nick Cave, Tom Waits. I grandi, i maledetti, i tormentati che si riaffacciano nella musica di Clementine. Un disco di una sconfinata, bellissima tristezza.
“Coming Home” – Leon Bridges
Le operazioni di nostalgia non mi hanno mai affascinato. Non eravamo in giro quando Otis Redding e Sam Cooke erano gli eroi di una generazione di neri d’America? Pace. Inutile provare a recuperare terreno con imitazioni così mal riuscite da suscitare nient’altro che tristezza. Epperò poi arriva Leon Bridges e tu prova a resistergli. Un 27enne afroamericano da Fort Worth, Texas, che del suono vintage, dell’arrangiamento retrò fa una religione. Il titolo e la copertina del disco, ‘Coming Home’; gli abiti eleganti che indossa: tutto in lui richiama a quell’eden della black music che si faceva tra gli studi della Stax a Memphis e i Muscle Shoals in Alabama. Bridges canta di amori timidi, del Mississippi, di New Orleans, della conversione di sua madre, di peccati e penitenze. E’ un gospel gentile, a tratti un po’ troppo ammaestrato. ‘Coming Home’ è un’ottima presentazione, chissà cosa verrà poi.
“La Vie Est Belle/Life Is Beautiful’ – Petite Noir
Ce lo vedete voi Dave Gahan, la voce dei Depeche Mode, a passeggio tre le periferie di Città del capo? Difficile, ma dopo aver ascoltato Petite Noir riuscirete a immaginarlo un po’. Nato in Belgio da padre congolese e madre angoliana, Petite Noir ha vissuto a lungo in Sudafrica. E’ l’archetipo dell’artista di questi tempi meticci, d’integrazioni difficili e sofferte. La sua voce profonda è uno dei suoni più riconoscibili di questo 2015. Poliritmie, basso ingombrante alla new wave anni 80, elettronica, un coro femminile che aggiunge un tocco di sensualità. Un sound unico, una somma di scariche elettriche che potrebbe prendere qualsiasi direzione. Finora hanno portato a ‘La Vie Est Belle/Life Is Beautiful’: un disco intenso, audace, attraente e inquietante. Come un viaggio attraverso due continenti.
“Ibeyi” – Ibeyi
Pensate ai suoni di James Blake cantati in inglese o in yoruba, la lingua nigeriana parlata da tanti schiavi portati fino a Cuba, da due giovani parigine che piangono il padre e la sorella. Suona triste? Non lasciatevi ingannare. L’omonimo debutto delle Ibeyi, duo composto dalle gemelle Lisa-Kaindé e Naomi Diaz, 19enni nate e cresciute a Parigi ma di origini cubane, figlie di un percussionista dei Buena Vista Social Club, è un elegante esercizio liberatorio, un dolore musicato. Percussioni afro, ritmi caraibici, beat elettronici. Un disco pieno di spazi, un lavoro di sottrazione: suoni distribuiti con parsimonia, non si soffoca mai. Spiritual transoceanico, soul modernissimo. Invocazioni di spiriti e preghiere antiche. Le voci s’incrociano, determinate e complici. Dopo l’attentato a Charlie Hebdo hanno marciato per Parigi, come tanti altri: “Benvenuto nel mio mondo, è un vero peccato. Abbiamo costruito un mondo folle, impegnato a combattere, a mentire e negare crudelmente”.
“From Kinshasa” – Mbongwana Star
In un mondo perfetto la canzone dell’estate di quest’anno sarebbe stata Kala, senza alcun dubbio. Un pezzo made in Congo su base techno tedesca, assemblato in Irlanda e cantato in una lingua incomprensibile. Ma visto che così non è stato, non ci resta che farla diventare la colonna sonora del Natale. I Mbongwana Star vengono appunto dal Congo, figli di quell’epica schiantata degli Staff Benda Bilili. La chiamano ‘world music’, ma di facilmente etichettabile c’è ben poco: psichedelia nera, trance elettronica, groove spazio-temporali, chitarre inafferrabili. ‘From Kinshasa’ è un disco che viene dal futuro, uno di quei rari tentativi (riusciti) di immaginare il suono del mondo che verrà. Fonte di gioia e speriamo d’ispirazione, è perfetto dall’inizio alla fine.
“Son Little” – Son Little
C’era un tempo in cui se volevi sentire della musica ‘americana’ non potevi sbagliare: Creedence Clearwater Revival, The Allman Brothers Band, The Band, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Muddy Waters. Poi le cose hanno preso una piega diversa: da una parte l’hip hop, il suono urbano dell’America nera; dall’altra il country da milioni di dischi, quel genere finito sotto il nome di ‘americana’ che ha prodotto mostri e stivali che ancora oggi intasano le classifiche d’oltre oceano. Son Little è qui per fare chiarezza. Il suo approccio al blues, rivisto e aggiornato, è il suono dell’America contemporanea. Un blend di rap, soul e rock. Ci sono rumori manipolati, sculacciate di chitarra e un basso molto, molto sfrontato. Son Little può essere sensuale, contemplativo, politico. Da ‘O Mother’: “Madre, perché mi trattano come se non fossi un uomo? Non resterò seduto a farmi trattare come uno schiavo”. Sorseggiare lentamente.
“In Colour” – Jamie XX
Indecisi per il capodanno? Montagna o città? Amici o parenti? Cotechino e lenticchie o capitone? Cominciate dalla musica, allora. Il disco perfetto per entrare nell’anno nuovo è ‘In Colour’, prova solista (con tanti ospiti) del dj Jamie XX, metà degli XX, uno dei gruppi più interessanti venuti fuori dall’Inghilterra negli ultimi anni. Quarantadue minuti di estasi con cui scaldarvi, pomiciare, ubriacarvi, scattare foto sgangherate nel cuore dell’ultima notte dell’anno, far sesso e ovviamente ballare, ballare fino a crollare per terra, con lo sguardo al soffitto e una coperta di drum’n’bass, pop, elettronica e malinconiche ballate tutt’intorno. Musica emozionante, perfetta nella sua meticolosa creazione, umana e accessibile a tutti: c’è un beat giusto per ogni gusto, decine di suoni con cui stupirsi, perdere la testa. Su ‘Loud Places’ c’è Romy Madley Croft, voce principale degli XX. Ascoltatela a palla: è il suol del futuro.
“What Went Down” – Foals
In un anno in cui il cosiddetto ‘indie rock’ ha prodotto poco e niente di realmente interessante, i Foals riescono a farsi notare. Non parliamo di una band dal suono innovativo, ma di un gruppo che in tre dischi (‘What Went Down’ è il quarto) è cresciuto e si definito sempre meglio. Stavolta il rischio era altissimo. Rinunciare a quelle distintive spigolature per diventare la nuova attrazione da stadio o insistere sulla strada meno battuta? Il risultato è una via di mezzo. Non uno sputtanamento totale, ma nemmeno una feroce presa di posizione. Ci sono momenti in cui il disco funziona alla grande: sono quelli in cui la voglia di sentirsi coatti, almeno per un giorno, va assecondata senza troppe domande. Rock da automobile, pogo da festival: questa è la dimensione perfetta per i Foals. Quando ritmo e tensione calano, invece, la band esce di strada.
“Shedding Skin” – Ghostpoet
Io me lo immagino di notte, mentre porta a spasso il suo cockapoo Oscar per le strade di Londra. Tra gente che beve, cammina senza una direzione sotto la pioggia, bottiglie vuote e cicche in terra, una coppia che si lascia: “Il problema è che ti ho già dimenticato, mentre io voglio la magia e le stelle, chiedo troppo?”. ‘Shedding Skin’ è il terzo disco di Obaro Ejimiwe, in arte Ghostpoet. Dal trip hop alla Tricky degli esordi qui si passa a musica suonata: una batteria ansiosa, un basso arrogante, una chitarra che s’insinua in ogni spazio. Un po’ cantando e un po’ rappando, Ghostpoet si aggira per Londra e noi con lui. Lo ascoltiamo mentre vaga per le vie della metropoli: dense, nervose, imprevedibili. Pellegrinaggi urbani a caccia di storie. Non fatevi intimorire da qualche eccesso claustrofobico, ‘Shedding Skin’ è il disco giusto per le vostre notti agitate.
“The Epic” – Kamasi Washington
Tra le tante cose, ricorderò questo 2015 come l’anno in cui un jazzista contemporaneo ha prodotto un disco coraggioso, accessibile, superbo. Parlo del debutto del sassofonista Kamasi Washington, ‘The Epic’. Nomen omen: tre ore di musica, album triplo, una band di 10 persone a cui si aggiungono cantanti, un’orchestra di 32 elementi, un coro di 20 voci. Non vi spaventate: ‘The Epic’ è un rimedio contro il rumore, contro il dover ricorrere (quasi) sempre a dischi di cinquant’anni fa per sentire del buon jazz. Lo potete assumere a piccole dosi, una canzone per volta; aumentarne il dosaggio, ascoltando un disco intero; o tutto insieme. Swing, funk, poliritmie, John Coltrane, Donald Byrd, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Marvin Gaye. Non siate timidi, avvicinatevi. Non fate complimenti, servitevi. Il jazz è ancora vivo.
di Antonio Bravetti – Giornalista professionista
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it